martedì 3 maggio 2011 - Incontri
Dopo la presentazione dello scorso settembre al Festival di Venezia, all’interno della Settimana della Critica, esce in sala venerdì 6 maggio Hai paura del buio, distribuito dalla Bim. Scritto e diretto da Massimo Coppola, ideatore e conduttore di alcuni dei programmi che hanno fatto la personalità di Mtv Italia, da "Brand: New" ad "Avere Ventanni", il film racconta una doppia presa di coscienza al femminile. La rumena Alexandra Pirici è Eva, una ragazza di Bucarest che, nel momento in cui non si vede rinnovato il contratto in fabbrica, decide di partire per l’Italia per regolare i conti col passato e inventarsi un futuro, mentre Erica Fontana è Anna, la coetanea di Melfi, turnista alla FIAT, che l’accoglie nella propria casa senza conoscerla, quasi senza parlarle ma, grazie a lei, finirà per scoprire molto di sé, di ciò che (si) teneva nascosto ed inespresso.
Perché un lungometraggio di finzione? Perché ad un certo punto hai preferito il linguaggio del cinema a quello della televisione o del documentario, che già frequentavi?
In realtà non ho una carriera da difendere e non ho nessuna velleità specialistica; forse non ho nemmeno nessuna vocazione precisa. Mi è venuta un’idea, mi sono messo a scriverla, ho parlato con la Indigo Film, loro hanno apprezzato il progetto, l’hanno condiviso ed è nato il film. Ma è vero che da ragazzino il desiderio di fare un film, un giorno, era in cima alla lista.
Rispetto a quel sogno di ragazzino, ora che il film lo hai fatto, qual è il bilancio?
Tutto ciò che immagini è più bello di ciò che fai. Sempre e comunque. Bisogna solo abituarcisi.
L’ambientazione di una parte del film e la scelta registica di “pedinare” i personaggi fa pensare che tu possa aver assorbito e riproposto una certa estetica del cinema rumeno contemporaneo. Ti ritrovi?
Credo che i motivi per cui si pensa che io sia legato al cinema rumeno siano in realtà legati soltanto a delle mode. Pedinare il personaggio è quello che ho sempre fatto nei miei documentari e all’epoca non c’era anche nessuna nuova onda del cinema rumeno. I riferimenti nel tempo, allora, vanno cercati più indietro. Per esempio, prima di mettermi a lavorare ad “Avere Ventanni” ho guardato ai primi esperimenti di quel tipo, agli anni ’30, ’40, ’50 del cinema. Non credo che il cinema rumeno contemporaneo mi abbia influenzato, per di più la scelta della Romania non è narrativamente vincolante: la vicenda di Eva avrebbe potuto essere ambientata anche in Bulgaria o in Bielorussia o in Ucrania, non racconto nessuna specificità rumena. Sono andato a Bucarest probabilmente perché tra le capitali dell’Est Europa è la più cosmopolita e quindi mi aiutava a sfatare un’inversione della realtà molto comune, per cui per tutti gli italiani la rumena è una signora col foulard e una borsa di ortaggi in un villaggio infangato, e crediamo che l’Italia invece sia molto più avanti. Al contrario, ci sono migliaia di ragazze come Eva a Bucarest, che abitano al dodicesimo piano di un palazzo del centro, nel mezzo di una moderna metropoli a tutti gli effetti.
Dunque la distanza sociale è un falso mito, ma tu racconti anche un’altra distanza, quella generazionale. Eva viene in Italia per dire alla madre: “hai sbagliato tutto”.
Assolutamente sì. Eva è un personaggio che invidio e che ammiro, perché ha la capacità di affrontare il proprio dolore anziché vivere nell’oblio. Quello che per me è centrale è il rapporto tra delle istanze sociali che appaiono scontate e il modo in cui l’individuo soffre di questi meccanismi. Eva viene a dire alla madre delle cose precise, cose che, quando mi sono venute in mente, mi sono apparse incredibilmente semplici ma anche incredibilmente non dette.
Il lavoro che hai fatto sul suono è molto curato e si scarta visibilmente dall’approccio medio italiano a questo settore della costruzione di un film. A tratti sembra tu voglia innescare una sinfonia industriale; altrove, spesso, ti interessa più togliere che aggiungere. Come concepisci la colonna sonora di un film?
Questa è una cosa a cui tengo molto. I miei lavori sono spessi caduti nel calderone del cosiddetto realismo o neorealismo, forse per facilità di definizione, ma in realtà io ho sempre cercato di fare un lavoro molto diverso. Ho un rapporto con la realtà che è nevrotico, molto personale e soprattutto astratto. Hai ragione a dire che ho lavorato a togliere piuttosto che ad aggiungere: la prima cosa che ho detto allo scenografo, Paolo Bonfini, col quale ho lavorato benissimo, è stata proprio questa: “dobbiamo raggiungere la realtà attraverso l’astrazione, non attraverso la mimesi”. E la stessa cosa ho fatto con la musica e con i suoni. Cosa significa praticamente? Significa che se sto girando una scena e c’è un cane che abbaia, non fermo certo le riprese per questo, non m’importa se una parola si sentirà peggio, perché quel cane è qualcosa a cui io devo reagire. In fabbrica, invece, dove ho la possibilità di ricreare un suono e di fare un lavoro complementare a quello fatto con la colonna sonora, lì lavoro d’astrazione, compongo o almeno provo a comporre una sinfonia industriale che stia nel mezzo, che venga còlta come tale da chi ha delle orecchie un po’ più raffinate ma che sia anche naturalistica. È un lavoro di astrazione, perché siamo partiti da 150 tracce delle quali ne sono rimaste ben poche ma c’è un ritmo che testimonia l’intervento d’autore. Così è anche per la colonna sonora, che è totalmente diegetica – poiché non sopporto le colonne sonore che inducono all’emozione attraverso “un re minore”, mi sembra davvero una furberia di bassa lega - ma al tempo stesso è usata per sottolineare lo stile del film. Essendo il montaggio un limite all’espressione visiva, per come la penso io, si può trasformare in una risorsa solo se lo si sottolinea. Il taglio nel mio film è crudo, sospeso, la musica s’interrompe bruscamente molto spesso e non dove ti aspetti che s’interrompa. Taglio i pezzi dei Joy Division non appena comincia il ritornello, il che è un po’ sadico, effettivamente, perché è proprio il momento in cui dovresti entrare nella canzone e invece te ne vai, ma è tutto parte di una costruzione che procede per sottrazione fino alla sequenza cruciale del film, quasi nel finale, dove invece c’è un eccesso di verbalizzazione, che dà luogo ad una scena quasi letteraria o teatrale. Volevo questa opposizione, l’ho ricercata appositamente.
Il lavoro di scrittura del film, che hai fatto in assoluta autonomia, è stato travagliato o relativamente semplice?
Tutt’altro che travagliato. La cosa difficile quando fai un film è avere a che fare con tutte quelle cose che non richiedono un lavoro intellettuale ma una prestazione manageriale. Scrivi un film ma poi diventi il manager della tua idea e devi cercare di coinvolgere gli altri. La prima stesura della sceneggiatura l’ho scritta molto velocemente, a Cuba, in dieci giorni. Sulla base di quella sceneggiatura la Indigo ha raccolto i finanziamenti e chiuso i contratti di distribuzione e poi, a tre mesi dalle riprese, l’ho riscritta quasi completamente, all’80%. Per esempio la scena del confronto tra Eva e sua madre l’ho scritta in quel momento, prima non esisteva proprio. All’inizio del processo di scrittura del film le due ragazze erano veramente complementari e un po’ l’una lo specchio dell’altra. Poi ho deciso di spostare l’asse temporale e di fare una staffetta, per cui la fine del percorso di conoscenza di Eva coincide con l’inizio del percorso di Anna. A questo punto non c’è più nessuno specchio: è Anna che guarda ad Eva e, ad un certo punto del film, specie con la chiusura della fabbrica, si rende conto di cos’è la sua vita: esattamente ciò che aveva fatto Eva all’inizio.
Hai improvvisato?
Ho improvvisato molto, ma sulla base di una sceneggiatura scritta e definitiva, che poi è cambiata ovviamente moltissimo durante le riprese e ancora di più al montaggio. Nessun livello di preparazione di un film è mai definitivo ma tu lo devi percepire come tale per avere una guida. Proprio la sicurezza che sia definitivo ti dà la forza per dire “ok, in realtà voglio fare tutt’altro”.
Il tono, il sonoro, il racconto… “Hai paura del buio” è un film poco italiano?
Mi rattrista la sensazione di sollievo quando me lo dicono. Vorrei tanto che l’aggettivo “italiano” tornasse ad essere qualcosa di cui andare fieri, però di fatto non posso fare finta di niente: che il mio film non sembra un film italiano è una cosa che mi dicono tutti e una delle poche sicurezze di cui dispongo. Chi mi dice questo, a quanto ho capito, intende dire che il mio film ha un linguaggio visivo – cosa evidentemente non scontata - e che non sta dentro l’ultrasemplificazione per cui devono esistere per forza solo o le commedie o i film tristi. Io trovo più triste una commedia becera di un film in cui una bella ragazza, molto indipendente, che ascolta i Joy Division, ti mostra come fare a riprendersi la propria vita. Vorrei che il mio film fosse in qualche modo, come dicono gli americani, “inspirational”, perché ci vedo un lieto fine: il modo in cui Eva alla fine affronta la madre per me è un happy ending, anche se forse più da film della Nouvelle Vague che da commedia con rutti e peti.
Salta agli occhi la tua grande fascinazione di regista per le protagoniste, specie per l’attrice che interpreta Anna. Che tipo di direttore di attori sei? Come lavori con loro?
Oggettivamente c’è stata una grande differenza nel rapporto con Alexandra e Erica. Alexandra è un’attrice con una buona esperienza, per di più anche una performer, quindi un po’ regista delle cose che fa. Con lei c’è stata grande condivisione di una certa sensibilità, fatta di sobrietà ma anche di giocosità al contempo, della volontà di affrontare la difficoltà di alcune scene di Eva in maniera molto diretta e molto franca. Ed è stata una scelta giusta, perché era l’unico modo per evitare la retorica. Con Alexandra, dunque, il rapporto è stato molto intellettuale. Viceversa, Erica era la prima volta che stava davanti ad una macchina da presa e mi sono reso conto il primo giorno, quando si è battuto il primo ciak, che a lei il ciak non accendeva nessun campanello. Su un set, normalmente, è un momento che cambia tutto: attori, tecnici, il regista… tutti entrano nell’atmosfera della ripresa. Ad un certo punto, invece, ho alzato gli occhi dal monitor e ho visto che, mentre tutti gli altri erano pronti, lei si guardava intorno senza capire. In più, Erica non ha tecnica, perché non è un’attrice, per cui il lavoro è stato molto diverso: si trattava soprattutto di provocarle delle reali emozioni, a volte anche con una certa durezza. Nella scena della discoteca di Napoli lei è stata realmente molto male, ma era l’unico modo per far sì che riuscisse ad esprimere un dramma così complesso.
Rispetto al mondo dell’arte e della televisione, fare cinema significa confrontarsi anche con un altro contesto: spettatori, critici, produttori, uffici stampa, festival, interviste, colleghi… Come te la cavi?
Come sempre: sto molto male e faccio finta che non sia così. Faccio anche l’editore, faccio televisione… ma non cambia. Ci sono delle piccole differenze antropologiche, divertenti da notare, ma in fondo è uguale. Per me è ancora emozionante. Tre settimane fa c’è stata l’ennesima riunione per il mio film alla Bim. C’erano venti persone in una stanza, da Valerio De Paolis, il capo, ai ragazzetti che si occupano del web-marketing: venti persone intelligenti che, con passione, cercavano di capire come fare a promuovere il mio film, che è oggettivamente un film difficile, per la situazione italiana e per l’educazione degli spettatori e gli strumenti che hanno a disposizione. Queste persone hanno investito dei soldi e degli sforzi e io provo per loro una gratitudine senza fine. Questo per dire che le risorse in Italia esistono e sono tante, purtroppo è vero anche che abbiamo dei problemi strutturali: ci sono monopòli in ogni ambito e non c’è spazio per le idee. Ci sono solo spazi occupati da chi ha il potere di occuparli, il che è una cosa veramente disgustosa.
Dunque il tuo incontro con la Indigo può essere definito, a maggior ragione, una vera fortuna…
Sì, ma perché le affinità elettive esistono e per fortuna valgono qualcosa. Conosco Nicola Giuliano e Francesca Cima da tanti anni, perché hanno prodotto il mio primo documentario nel 2000, e sono fantastici.
Hai paura del buio?
Sì, certo. Il buio che racconto è anche il mio. Racconto le donne perché sono infinitamente superiori agli uomini e perché secondo me il cinema è il volto di una donna, perché contiene tutto, è come "L’Origine del Mondo", il meraviglioso dipinto di Courbet. Il sogno è fare quella cosa lì e ci si prova con i volti delle donne. Io non ho la forza che ha Eva, tendo piuttosto all’oblio, alla rimasticazione solitaria, ma quando faccio una cosa ci sono dentro emotivamente e completamente, non mi pongo mai al di sopra: il loro buio è anche il mio.

 Home
Home
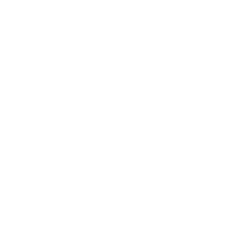 Seguici su Facebook
Seguici su Facebook
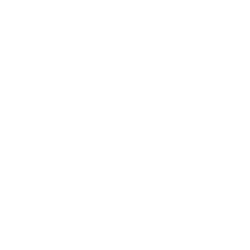 Seguici su Twitter
Seguici su Twitter
 Seguici su Flipboard
Seguici su Flipboard
 Cerca
Cerca