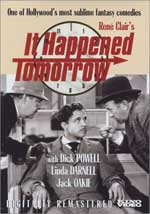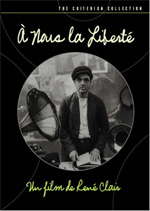- Film 2026
- Film 2025
- Film 2024
- Film 2023
- Film 2022
- Film 2021
- Film 2020
- Film 2019
- Film 2018
- Film uscita
- Film da vedere
- Film al cinema
- Film commedia
- Film d'animazione
- Film horror
- Film thriller
- Film d'azione
- Film imperdibili
- Film imperdibili 2026
- Film imperdibili 2025
- Film imperdibili 2024
- Film imperdibili 2023
- Film imperdibili 2022
- Film imperdibili 2021
- Film imperdibili 2020
- Film imperdibili 2019
- Trailer
- Serie TV - Tutte le novità
- Serie TV 2026
- Serie TV 2025
- Serie TV 2024
- Serie TV 2023
- Serie TV 2022
- Serie TV 2021
- Serie TV 2020
- Le serie tv imperdibili del 2026
- Le serie tv imperdibili del 2025
- Le serie tv imperdibili del 2024
- Le serie tv imperdibili del 2023
- Le serie tv imperdibili del 2022
- Le serie tv imperdibili del 2021
- Le serie tv imperdibili del 2020
- Berlinale
- Oscar
- International Film Festival Rotterdam
- EFA 2026
- Artekino Festival 2025
- River to River
- Torino Film Festival
- Festival dei Popoli
- France Odeon
- Festa del Cinema di Roma
- Alice nella città
- Mostra del Cinema di Venezia
- Locarno Festival
- Ischia Global Fest
- Biografilm
- Cannes Film Festival
- Far East Film Festival
- David di Donatello
- Capri Hollywood
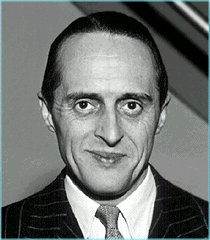
Nascita: 11 novembre 1898
Morte: 15 marzo 1981






![Dieci piccoli indiani [1] Dieci piccoli indiani [1]](https://pad.mymovies.it/filmclub/2002/08/024/imm.jpg)