



Raffaello Matarazzo è un regista, scrittore, sceneggiatore, montatore, assistente alla regia, è nato il 17 agosto 1909 a Roma (Italia) ed è morto il 17 maggio 1966 all'età di 56 anni a Roma (Italia).
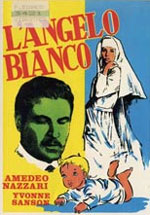 Esordi nel cinema come regista con Treno popolane (1933). Da allora ha realizzato numerosissimi film, nei generi più diversi, affermandosi tra i registi italiani più attivi e di successo nel periodo prebellico. Nel dopoguerra la sua fortuna di regista fu legata soprattutto alla serie dei film di appendice, forti drammi popolari, sentimentali e lacrimogeni, che ebbero uno strepitoso successo di pubblico: da Catene (1950) a Tormento (1951) a I figli di nessuno a Chi è senza peccato (1953), fino a Torna! (1954) e L'angelo bianco (1955), tutti interpretati dalla coppia Amedeo Nazzari - Yvonne Sanson. In questi, e in altri film dello stesso genere, Matarazzo dimostrò, oltre un buon mestiere e una corretta fattura, un abilissimo senso dello spettacolo e un'eccellente conoscenza della psicologia popolare di quegli anni, così che i suoi film possono utilmente essere studiati come fenomeno di costume di un periodo ben preciso della nostra storia recente.
Esordi nel cinema come regista con Treno popolane (1933). Da allora ha realizzato numerosissimi film, nei generi più diversi, affermandosi tra i registi italiani più attivi e di successo nel periodo prebellico. Nel dopoguerra la sua fortuna di regista fu legata soprattutto alla serie dei film di appendice, forti drammi popolari, sentimentali e lacrimogeni, che ebbero uno strepitoso successo di pubblico: da Catene (1950) a Tormento (1951) a I figli di nessuno a Chi è senza peccato (1953), fino a Torna! (1954) e L'angelo bianco (1955), tutti interpretati dalla coppia Amedeo Nazzari - Yvonne Sanson. In questi, e in altri film dello stesso genere, Matarazzo dimostrò, oltre un buon mestiere e una corretta fattura, un abilissimo senso dello spettacolo e un'eccellente conoscenza della psicologia popolare di quegli anni, così che i suoi film possono utilmente essere studiati come fenomeno di costume di un periodo ben preciso della nostra storia recente.